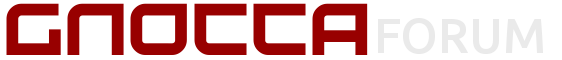Allora, ... non scherziamo su io so, tu sai... sono concetti per me superati... e da un bel po'!!!
Chi ha qualcosa da comunicare... badate... comunicare!!! Se è una persona intelligente lo fa, senza remore o vanti.. lo scrive, al servizio e per gli altri che, se ne hanno piacere: apprezzano, altrimenti passano oltre!!!
Penso di aver chiarito a fondo il concetto della comunicazione, come s'intende nei paesi anglosassoni.... i quali farebbero carte false, per avere la nostra cultura umanistica... ma, questo è ancora un altro .. ciulè!!!
Passiamo ora ad esporre la seconda parte dello studio, sull'importanza del vino nel Risorgimento Italiano,.... nel dettaglio, per capire meglio l'argomento.
La Provincia di Cuneo ed in particolare le Langhe, possiedono una storia ed una cultura vitivinicola senza pari, nonostante che parlare di vino faccia correre il pensiero ai francesi. Da prima della Rivoluzione Francese, Bordeaux, Borgogna e le terre dello Champagne erano regine della cultura del buon bere.
Nel 1800 l'Italia era ancora suddivisa in tanti staterelli, la cultura, la filosofia dei nostri produttori, la mancanza di acquirenti esigenti e l’assenza di una vera e propria disciplina scientifica, in campo enologico, non hanno permesso la nobilitazione del nostro vino.
Il primo segnale di riscossa venne in Toscana dal Granduca Leopoldo II, che era un Asburgo, il quale alla morte del padre Ferdinando III, nel 1824, salì al trono e negli anni del suo regno riuscì a creare all’Accademia dei Georgofili di Firenze una facoltà che studiasse l’argomento.
Convinse e stimolò i nobili proprietari terrieri e produttori di vino ad acculturarsi, a crescere, capofila fu il Barone Bettino Ricasoli che, nella sua tenuta del Castello di Broglio, elevò il Chianti, con disciplinare e regole ferree di produzione, a vino internazionale.
Pensate, l’ironia della sorte quest’uomo, Leopoldo II, era il cognato di Re Carlo Alberto, in quanto quest’ultimo aveva sposato sua sorella Maria Teresa d’Asburgo Lorena, infine fu cacciato da suo nipote Re Vittorio Emanuele II, figlio della sorella succitata!!!
Nel piccolo Regno di Sardegna invece, come un faro che si accende nella notte buia e cupa delle Langhe, il Conte Camillo Benso di Cavour: venne nominato Sindaco del Comune di Grinzane, nel maggio del 1832, coprirà tale incarico fino al Febbraio del 1849, quando fu chiamato a Torino, come Ministro del Regno.
Da quel momento l’enologia Piemontese incomincia a galoppare: frutto dei suoi viaggi all’estero, matura esperienze di Agricoltura che sperimenta nei suoi poderi con nuove ed innovative tecniche di analisi del terreno che determinavano la vocazione agricola delle particelle catastali, indicate con il tipo di vitigno da impiantare in maniera particolareggiata e minuziosa.
Oudart e Bruchè, due grandi enologi collaborarono alla progettazione dei vigneti, studiando ed usando nuove macchine agricole per la vigna, sperimentano inoltre, con successo, la concimazione con “Guano” e concime, ottenuto dalla lavorazione degli ossi degli animali, scarto della macellazione.
Tra l’altro tale industria di concimi era a Settimo Torinese ed usava lo scarto di lavorazione di un’altra industria, che trasformava gli ossi in colla e mangimi, che era in Borgo Vanchiglia a Torino, dalle parti di via Napione, in riva al Po. Ecco perché il Borgo Vanchiglia viene ancora oggi chiamato “Burg del fum” (Borgo del fumo), per l’olezzo ed il fumo che sprigionava tale opificio, funzionante 24 ore su 24!!!
Oltre ad incrociare cloni, per rinvigorire e rafforzare i vitigni locali ed autoctoni, in primis il “Nebbiolo”, impianta vigne a filari stretti, con pali di legno di castagno e gaggia (robinia), dalla punta “Temprata” o incatramata, o addirittura poi “Trattata” (come le traversine della ferrovia).
Non più viti che si arrampicano agli alberi, con fili tesi fra un albero e l’altro, non più coltivazioni fra i filari. Potature “corte” al fine di avere uva di qualità, favorendo quest’ultima nei confronti della quantità, non più mischiare le uve, ma ogni tipo d’uva fermentata a parte, dava così il proprio tipo di vino.
L’Oudart, infine risolse il problema della vinificazione e conservazione del vino, imponendo una pulizia maniacale nelle cantine, nelle botti e migliorò la tecnica di vinificazione.
Il Cav. Luigi Oudart, nato a Reims, era un Matematico ma, ancor più: distinto ed appassionato viticoltore ed enologo, conosciuto dal Cavour a Genova, dove curava il commercio dei vini Francesi. Si trasferì a Grinzane, verso il 1840, quivi si avvalse della preziosa collaborazione del valente agronomo torinese: Matteo Bonafus (1794 – 1852), a cui fu intitolato l’Istituto Superiore d’Agraria di Torino.
Con la pulizia, la raccolta dell’uva perfettamente matura, permise una fermentazione completa, dove tutti gli zuccheri venivano trasformati in alcool, a temperature ragionevolmente basse, per far mantenere i profumi al vino.
Pensate, è di quei tempi il Regio decreto che ogni vitigno, aveva una data minima, anteriormente alla quale, non si poteva vendemmiare, per garantirne la piena avvenuta maturazione e sviluppo degli zuccheri, con conseguente formazione sulle bucce, degli zucchero-miceti.
Grazie ad Oudart, Bruchè e Staglieno, si imparò inoltre a bruciare lo zolfo all’interno delle botti vuote, al fine di &ldquo

isinfettarle” e di far morire i rimanenti batteri, che non venivano eliminati con la sola pulizia, con brusca ed acqua calda, poi in seguito mischiata con “Soda Caustica”.
Tutte le innovazioni suaccennate, visti i risultati ottenuti, vennero pian piano esportate in tutta la Langa e poi nell’intero Piemonte, ancora oggi i “Langhet” ricordano che gli sono stati tramandati, dai propri avi, i metodi vitivinicoli: “del Cunt”, riferendosi al grande Camillo Benso, Conte di Cavour.
I più convinti assertori delle tecniche dell’Oudart, oltre al “Cunt”, furono prima i Marchesi Falletti di Barolo: Carlo Tancredi e la moglie Juliette Colbert, discendente del Ministro delle Finanze del Re Sole, e poi lo stesso Re Vittorio Emanuele II, che aveva acquistato la tenuta di Fontanafredda, come rifugio d’amore per la sua “Bela Rusin”, Rosa Vercellana, nominata poi Contessa di Mirafiori e sposata “Morganaticamente”, dopo la morte della Regina: Maria Adelaide, figlia di Maria Elisabetta di Savoia, sorella di Re Carlo Alberto.
Il Barolo moderno nacque in questo modo, da uve Nebbiolo, con rigido disciplinare che prevedeva un invecchiamento in botti pulite (“arcalà”, cioè raschiate fino sul legno vergine e “sufrà”, cioè solforate), di rovere o castagno selvatico, per almeno 5 anni, ottenendo così un vino forte, di almeno 14° alcolici, dal colore rubino, ricco di profumi, asciutto, destinato all’affinamento in bottiglia, per poi un ulteriore invecchiamento, onde nobilitare e mitizzare tale bottiglia di Barolo, rigorosamente millesimata!!!
Ancor oggi è tradizione, nelle Langhe , in occasioni e ricorrenze particolari, quali matrimoni, compleanni, nozze d’oro o d’argento, ecc., al culmine della festa stappare una o più bottiglie di Barolo, dell’annata dell’anno di nascita o di matrimonio, del o dei festeggiati!!!